In Profondità
Maternità e tossicodipendenza
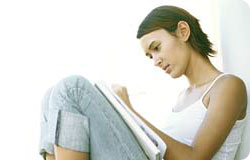
Gli effetti dell’uso di sostanze psicoattive sulla gravidanza
Di seguito vengono elencati degli effetti la cui entità è molto legata alla dose
(maggiore è la dose, maggiori gli effetti collaterali); tuttavia è opportuno ricordare come da un punto
di vista comportamentale, l’assunzione di tali dosi non è necessariamente limitata ai tossicodipendenti
veri e propri, ma può riguardare anche soggetti dediti più o meno saltuariamente a comportamenti d’abuso.
- Complicazioni ostetriche
Le più importanti complicazioni ostetriche che si verificano
nella gestante tossicomane sono attribuibili all’effetto delle sostanze d’abuso sull’utero gravido
e/o sulla vascolarizzazione placentare.
Fra le complicazioni acute, correlate soprattutto
all’assunzione irregolare di dosi elevate, si registrano distacchi placentari, aborti e parti
prematuri. In caso di assunzione cronica, il meccanismo ischemico è responsabile di sofferenza
fetale e dismaturità (feti piccoli per età gestazionale), condizioni che espongono il neonato ad
un accresciuto rischio di contrarre numerose patologie ostetriche e neonatali.
Neonati di basso peso si riscontrano comunemente nella progenie di donne che abusano di oppiacei,
di cocaina, di marijuana, di tabacco.
- Tetratogenesi
In merito all’effetto diretto delle sostanze psicoattive sullo sviluppo dell’organismo,
si possono descrivere schematicamente due categorie di fenomeni: l’evidenza di alterazione
morfogenetica
(alterazione della forma del corpo e dei suoi organi durante lo sviluppo
embrionale) da un lato (tetratogenesi propriamente detta) e gli effetti neurali e comportamentali
in assenza di alterazione anatomica dimostrabile (tetratogenesi neurocomportamentale) dall’altro.
I meccanismi della tetratogenesi anatomica sono ancora scarsamente conosciuti; essi sarebbero
collegati o con le interferenze che si verificano a carico della migrazione delle cellule embrionali
o con turbe della vascolarizzazione degli abbozzi morfogenetici. Una chiara tetratogenesi
morfologica è nota per l’alcol (sindrome fetale alcolica: difetto di accrescimento, microcefalia,
dismorfie della faccia e degli arti, segni di irritabilità cerebrale con deficit di apprendimento),
per la cocaina (malformazioni genito-urinarie ed esiti di alterazioni cerebrali ischemiche),
per le anfetamine e l’LSD.
Secondo recenti segnalazioni epidemiologiche, l’uso di marijuana
in gravidanza si assocerebbe ad un’aumentata incidenza di leucemie acute infantili.
La tetratogenesi neuro-comportamentale è costituita dalla persistenza post-natale di
alterazioni a carico di funzioni neuropsichiatriche essendo cessata l’esposizione alla sostanza
psicoattiva.
- Problemi neonatali
Si possono distinguere effetti da impregnazione e da sospensione. Le sostanze che deprimono il
sistema nervoso centrale (come gli oppiacei, le benzodiazepine, i barbiturici) sono responsabili
di difficoltà respiratorie al momento della nascita per meccanismi di accumulo, dalle quali possono
conseguire danni neurologici molto gravi.
Al contrario, la sindrome astinenziale del neonato
si presenta come una sindrome di ipereccitabilità generalizzata dei sistemi neurali vegetativi e
di relazione che dipende dalla brusca interruzione nell’assunzione di droga, introdotta
nell’organismo fetale sino al momento della nascita attraverso gli scambi umorali con l’organismo
materno. La sindrome viene trattata mediante somministrazione a scalare di agonisti della sostanza
d’abuso (per esempio metadone o morfina nel caso degli oppiacei). Se il dosaggio assunto dalla
madre nelle ultime fasi della gestazione non era particolarmente elevato e la terapia neonatali
viene eseguita correttamente, la sindrome non lascia reliquari specifici.

Le conseguenze dello stile di vita della gestante tossicodipendente
Da un punto di vista medico, la gestazione della donna tossicodipendente,
viene considerata una gravidanza a rischio nel suo complesso.
- Malattie infettive
Sono di natura infettiva le più importanti patologie correlate allo stile di vita tossicomanico.
Un primo gruppo è costituito dalle patologie infettive trasmissibili al feto durante la gestazione
e/o al neonato nel momento del parto. Fra queste occorre ricordare le epatiti (soprattutto da HBV)
e l’infezione da cytomegalovirus, in relazione all’uso di siringhe; le malattie sessualmente
trasmesse, legate alla promiscuità dei costumi e/o ad un basso livello di cultura
igienico-sanitaria, tra cui lue (malattia infettiva altrimenti detta sifilide), gonorrea,
infezioni da chlamydiae e da herpes genitalis (HSV). L’infezione da HIV, trasmessa orizzontalmente
con lo scambio di siringhe e con i rapporti sessuali, ha una probabilità di trasmissione verticale
(madre-figlio) dell’ordine del 50%; il virus può infettare il feto in utero, contaminare il neonato
durante il parto od essere trasmesso con l’allattamento. Questo gruppo di infezioni determina
malattia nel feto, con effetti anche molto gravi, che giungono alle malformazioni e alla morte
in utero.
Il secondo gruppo di patologie infettive è prodotto dagli agenti che determinano uno scadimento
delle condizioni materne con ripercussioni dirette o indirette sul benessere fetale.
Sono da ricordare in proposito le infezioni da germi banali o funghi (soprattutto le endocarditi,
ovvero infiammazioni delle cellule che rivestono le pareti interne del cuore), anch’esse legate
alle pratiche iniettive senza precauzione igienica, e la tubercolosi, divenuta oggi frequente nei
soggetti con immunodeficienza. Queste infezioni materne possono condurre a danni fetali di gravità
variabile, sino alla morte in utero.
- Altre malattie
Fra le patologie non infettive, ancora su base eminentemente comportamentale, ricordiamo gli
stati di cattiva nutrizione dovuti all’alimentazione incongrua, nonché le conseguenze della scarsa
cura della persona in genere.

I problemi assistenziali per una donna tossicodipendente in gravidanza
Le donne tossicodipendenti soffrono di una notevole alterazione dei vissuti della gravidanza:
da ciò derivano spesso atteggiamenti noncuranti di perseverazione o, all’opposto, fantasie eroiche di
cambiamento radicale circa la propria condizione tossicomanica; a volte la scoperta della gravidanza si
associa addirittura ad un’incrementata assunzione di sostanze psicotrope, probabilmente in relazione
alle angosce provocate dall’evento. La richiesta di intervento assistenziale da parte delle gestanti
tossicodipendenti risente negativamente di tali dinamiche psicologiche: essa è sovente tardiva e, quindi,
responsabile di un ulteriore e cospicuo aumento di rischio per la salute del neonato.
La gestione tossicologica della gravidanza è stata messa a punto secondo protocolli terapeutici
che prevedono generalmente la sostituzione della droga di strada con la somministrazione regolare di
metadone. Il mantenimento metadonico viene effettuato alla più bassa dose compatibile con la prevenzione
delle recidive, che viene ricercata mediante scalaggio lento. Da un punto di vista ostetrico lo scalaggio
viene effettuato di preferenza fra la 14esima e la 32esima settimana di gestazione, compatibilmente con
le condizioni psicosociali della donna.
La completa disintossicazione della madre è ragionevolmente
attuabile quando si disponga di un supporto ambientale adeguato, in assenza del quale è preferibile adire
al mantenimento metadonico. Tale approccio consente di evitare lo stress fetale dovuto all’assunzione
intermittente di droga in caso di recidiva e consente un contatto continuo della gestante con i servizi
sanitari durante l’arco della gravidanza, sviluppando una maggiore disponibilità ad eseguire i controlli
di routine.
L’intervento di assistenza alla gravidanza in corso di tossicodipendenza si confronta con uno spettro
di bisogni e di problemi assai vasto, che richiedono competenze multidisciplinari.
Schematicamente possiamo elencare le seguenti aree:
- somatica: include l’ampia serie di problemi medici, ostetrici ed infettivologici;
- psicologica: la psico(pato)logia della maternità si interseca con la presenza di eventuali disturbi mentali concomitanti;
- relazionale: frequenti i casi di nucleo familiare acquisito disgregato o assente, nonché di partner tossicodipendente;
- socio-economico: basso livello culturale, difficoltà occupazionali e ricorso alla prostituzione costituiscono problemi non eccezionali;
- legale: oltre alle eventuali pendenze giudiziarie della madre connesse con attività illegali, può accadere che il destino del nascituro venga rimesso al tribunale dei minori per inadempienza, incapacità, vizio di mente, della madre come di entrambi i genitori.

Se la mamma tossicodipendente fosse anche sieropositiva
L’AIDS conclamato, rappresenta solo una piccola percentuale dei casi di infezione da HIV;
in altri termini, essi sono la punta visibile di un iceberg, la cui base sommersa, ben più ampia,
è costituita da tutte le persone sieropositive per anticorpi anti-HIV e quindi infette e contagianti.
Questa particolare distribuzione è imputabile al lungo periodo di latenza, valutato in media intorno ai
10 anni, che intercorre tra il momento reale dell’infezione e quello della comparsa della sintomatologia
specifica. In Italia la legge prescrive che
“Nessuno può essere sottoposto senza consenso ad analisi tendenti ad accertare l’infezione da HIV”.
L’attuale impossibilità, oltre che per motivi legali, anche per problemi economici, organizzativi ed etici,
ad eseguire un test popolazionistico per individuare tutte le persone infettate da HIV, rappresenta un
limite nel valutare correttamente la diffusione dell’infezione e l’efficacia delle strategie sanitarie
proposte per controllarla.
I modi con cui l’infezione da HIV può essere trasmessa:
- via sessuale nel corso di rapporti sessuali. Il virus è infatti presente nello sperma e nelle secrezioni vaginali dei soggetti contagiati;
- via parenterale, per somministrazione di sangue, emocomponenti o emoderivati infetti, ma anche per l’uso di aghi e siringhe contaminati;
- via verticale, dalla madre infetta al figlio. In questo caso l’infezione può essere trasmessa:
- durante il periodo prenatale, presumibilmente per via transplacentare;
- nel corso del parto, quando il neonato viene esposto al contatto con sangue e/o secrezioni cervico-vaginali contaminate dal virus;
- nel periodo post-natale, tramite l’allattamento al seno (pochi casi accertati).

Linee di intervento per una donna tossicodipendente in gravidanza
Per una soddisfacente gestione della gravidanza è necessario attivare un ampio ventaglio di supporti
socio-sanitari, ma soprattutto è necessario incentivare l’uso dei supporti assistenziali stessi da parte
delle pazienti sviluppando una compliance ai trattamenti.
Si è dimostrato infatti che, almeno nel
caso della dipendenza da oppiacei, un buon livello di cura prenatale annulla quasi completamente le
differenze di morbilità fra i gruppi di gestanti tossicodipendenti trattate con metadone e la popolazione
generale, differenze che sono invece assai significative fra i gruppi non trattati e i controlli.
Per quanto riguarda l’intervento assistenziale a favore della gestante, possiamo indicare quindi i
seguenti obiettivi principali:
- protezione biologica del feto, che richiede interventi tossicologici specifici e provvedimenti generali;
- sviluppo delle capacità materne, che necessita di un’attenzione specifica sin dalle prime fasi della gravidanza al fine di garantire la qualità della vita del bambino (sviluppo delle competenze psicologiche e capacità concrete nelle cure parentali);
- interventi sulle patologie concomitanti, che richiedono competenze specialistiche multidisciplinari che possono essere erogate in regime ambulatoriale e di degenza;
- supporto sociale, che costituisce un complemento indispensabile degli interventi di natura prettamente sanitaria.

I bambini nati da madre HIV-positiva
Nell’adulto, la presenza di anticorpi anti-HIV indica la coesistenza del virus; nel neonato invece,
la sieropositività non ha lo stesso significato in quanto può essere conseguente al passaggio
transplacentare dei soli anticorpi materni, ma non del virus.
Gli anticorpi di origine materna, che dimostrano l’infezione nella madre, possono scomparire a
partire dal quarto mese o persistere fino al quindicesimo-diciottesimo mese di vita.
Quindi, i nati da madre sieropositiva per anti-HIV sono alla nascita sempre sieropositivi, ma non
necessariamente infetti. Le modalità del parto, per via vaginale o parto cesareo, non sembrano
influenzare il rischio di trasmissione.

Il follow-up dei nati da madre positiva
Nei primi mesi di vita è difficile distinguere i bambini sieropositivi che hanno contratto l’infezione
da quelli sieropositivi sani. E’pertanto indispensabile predisporre per tutti i nati da madre
sieropositiva per anticorpi anti-HIV, dei programmi di follow-up che prevedano, oltre all’esecuzione
delle varie indagini di laboratorio, una attenta valutazione clinica per cogliere tempestivamente
possibili segni associati ad una infezione attiva da HIV. Per tale motivo è opportuno che il bambino
“a rischio” venga seguito da una equipe polispecialistica formata da pediatri, infettivologi, neurologi,
oculisti, chirurghi e altri, in grado di affrontare i molteplici problemi che un bambino HIV- positivo
può presentare.
Lo scopo di tali programmi è quello di identificare il paziente infetto prima
dell’insorgenza delle manifestazioni cliniche che, spesso, si possono cogliere solo in uno stadio
avanzato della malattia. In mancanza di una cura, la scienza medica dispone di farmaci che sono in grado
solo di rallentare il decorso della malattia e che risultano tanto più efficaci quanto più precoce è il
loro impiego.

Il decorso dell’infezione da HIV in età pediatrica
Il decorso in età pediatrica è più rapido che nell’adulto, soprattutto se il virus è stato trasmesso
per via verticale. In alcuni bambini, asintomatici per lungo tempo, l’infezione si può manifestare,
all’inizio, solo con alterazioni a carico del sistema immunitario; in altri invece, la sintomatologia
clinica ha un esordio molto più precoce, entro il primo semestre di vita, e più grave.
Sono frequenti in questa categoria le infezioni batteriche ricorrenti e le infezioni opportunistiche.
Ai gravosi impegni materiali, dovuti ai frequenti controlli clinici e ai ricoveri in ambiente
ospedaliero, si aggiunge un profondo coinvolgimento psicologico: spesso la madre si sente responsabile
della malattia del figlio e, oltre a seguire con estrema apprensione ogni possibile manifestazione
patologica, a volte non imputabile all’HIV, vive con ansia l’inserimento sociale del bambino,
temendo che egli possa andare incontro a discriminazioni ed emarginazione per il fatto di essere
sieropositivo.